CRISTALLO
No alla mastectomia
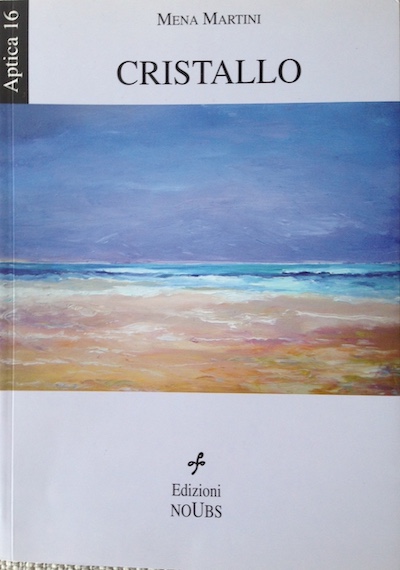
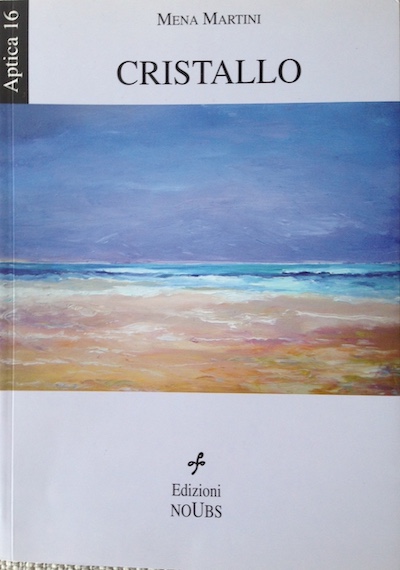
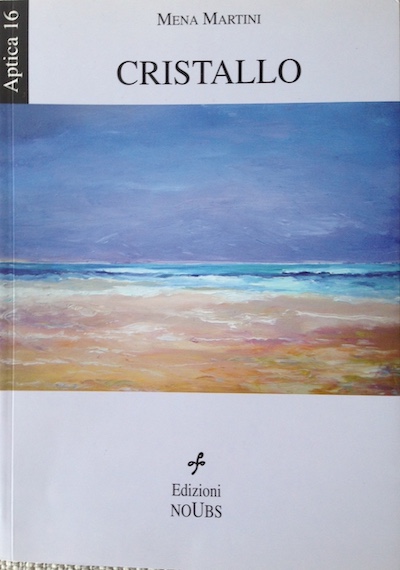
CLAUSOLA DI NON RESPONSABILITÀ
Il libro che segue è la storia, vera, di quando mi fu diagnosticato un cancro al seno nel 1990.
Rifiutai la mastectomia e la radioterapia che gli oncologi avevano raccomandato e preferii, per curarmi, metodi alternativi e complementari, non invasivi.
Con il mio testo Cristallo (titolo scelto per indicare la trasparenza della malattia, ma anche a ricordo delle lastre di vetro tra cui la mammella veniva schiacciata durante la mammografia) non intendo suggerire o convincere nessuno che il cammino da me intrapreso sia quello giusto.
La mia intenzione è quella di raccontare, di condividere, di far partecipe il lettore del mio mondo di speranza.
MI sveglio dall’anestesia su un letto d’ospedale, in una stanza dove tende blu cielo delimitano spazi e formano pareti. Sento respiri e mormorii confusi di corpi anonimi isolati da cortine di tende. Voglio lasciarmi andare e affondare nel dormiveglia, ma la voce di Mauro e quella del chirurgo mi scuotono dal torpore.
“Non sappiamo ancora nulla. Il campione preso durante la biopsia può essere di un tumore benigno o maligno, sembra difficile da identificare.”
“Quanti giorni ancora dottore?”
“Tre o quattro. Mi telefoni in ambulatorio.”
Il medico pare allontanarsi, ma poi la sua voce mi perviene vicina, dal cubicolo a fianco, dove qualcuno soffre e aspetta come me.
“Devo dirle signora che purtroppo si tratta di cancro… la biopsia ha confermato i miei timori. La opereremo fra qualche giorno.”
Le parla direttamente perché non c’è un marito ad interagire. È sbrigativo ed efficiente, non ha dubbi, non è giusto perdere tempo.
L’ammalata non risponde, respira soltanto, ed io sento pietà per lei, la pietà di un essere umano per un suo simile che sta soffrendo… ma anche sollievo per non essere al suo posto. Se il cancro ha colpito lei forse ha risparmiato me, se lei è ammalata forse io mi salverò, sarà quella sconosciuta a morire…
… e soltanto perché non la conosco, il suo dolore non sembra esistere, la sua vita non sembra vera…
Mauro solleva la tenda e si avvicina.
“Come stai?”
“Male… ho troppa nausea e tutto mi gira intorno. È per l’anestetico… se potessi vomitare.”
Chiamo mia madre, come faccio sempre quando sto male. Nel silenzio ascolto la mia voce come una ninna nanna che mi culla nel dolore, mamma, che male mamma, mamma, aiutami mamma, sempre più in silenzio, fino a quando la voce diventa sussurro e il sussurro lamento di animale ferito che non conosce parole.
L’infermiera sente i gemiti e si avvicina, ma non voglio nessuno, solo una bacinella. Dopo il vomito sto meglio, è la nausea che mi consuma. Il corpo mi duole a scatti, insistente, ma se non voglio prendere farmaci devo ritrovare nella memoria la forza di affrontare il dolore, come ho fatto in passato quand’ero in controllo della mia vita. Ci riuscivo solo se il male non era violento da stordirmi e se ci credevo intensamente, perché appena il dubbio prevaleva e la paura s’infiltrava, la larva diventava una tigre e il ticchettio una ruspa che stritolava la terra.
Il dolore mi divorava, lasciandomi allucinata.
Ricordo tuttavia un giorno magico.
Ero dal dentista che cercava di tirarmi un dente sbriciolato dalle tenaglie. Eravamo ambedue stremati perché continuavo a soffrire pur dopo ripetute anestesie. Ad un tratto non ce la feci più, mi aggrappai come ultima risorsa ad un esercizio di visualizzazione e mi scoprii a immaginare un campo di papaveri gialli al sole. Il giallo m’inondava la testa, il petto, le braccia, s’infilava nel corpo e s’impadroniva della mente. Dove prima c’erano tensione e paura ora il colore ammorbidiva e illuminava. Guardai il dentista affaticato in un ennesimo tentativo di strappo e dissi alla mente di cedere, di lasciar andare… e la radice si staccò soffice, senza un lamento.
Se potessi capire come funziona la mente umana, se potessi vederla sempre chiara ed ubbidiente come quel giorno, se potessi dirigerla dove e quando voglio, se…
Il seno destro mi brucia. È stato tagliato, aperto, non so quanto né dove. Vorrei massaggiarlo per alleviare il bruciore, ma non posso perché le bende coprono la ferita.
“Ti fa molto male?” Mauro con la sua voglia di aiutare.
“Un poco…. ho nausea, devo vomitare ancora. Avevo chiesto di non farmi l’anestesia totale, non volevo stare così male dopo. Per favore dammi la bacinella e poi vai via.”
Ritorna l’infermiera con sedativi e antinausea. Non ho nemmeno la forza di respingerla con convinzione, l’allontano con un gesto insieme alle medicine. Devo ancora vomitare e non voglio nessuno quando vomito, nessuno che senta ribrezzo nel vedere il marcio che ho dentro.
Il vomito mi dà un senso di liberazione, lasciandomi sottile come una foglia nel vento, ancora aggrappata all’albero, ancora viva…
… e nell’euforia del dopo nausea, quando tutto nella vita sembra bello, persino il dolore al seno appare secondario, un mormorio timido e in sordina.
Mi alzo, Mauro mi aiuta perché non posso muovere molto il braccio destro. Sono ancora stordita, ma voglio lasciare presto l’ospedale e tornare a casa dai bambini e dalle nonne arrivate da poco dall’Italia.
L’aria fuori è fredda e frizzante, pochi passi nella sera. Com’è bello essere vivi! E da quanto non me ne ricordavo più. Tutto sembra nuovo, vestito a festa apposta per me, persino le luci colorate del negozio di fronte, che si accendono e si spengono per mandarmi messaggi segreti. Mi guardo intorno come se fossi in un mondo nuovo, pervasa da un senso di gratitudine.
Peccato che mi senta così solo quando la vita si veste di tragico!
Stamattina.
Era solo stamattina che siamo venuti in ospedale, eppure quanto tempo sembra essere passato.
In cammino, ascoltavo i nostri passi nel silenzio di una città addormentata, sotto un cielo terso e su strade di neve rosata dalla prima luce del giorno. Accanto a case silenziose, sotto alberi bianchi, il mio corpo pareva così prezioso nel suo esistere… pareva soltanto, perché a ghignare beffarda balzava nella mente la mammografia.
Se solo non ci fosse stato lo spettro del cancro
come sarebbe stata bella la mia vita
eppure…
si trattava di questa vita di sempre
stanca difficile e ripetitiva
che solo nei momenti di dramma intenso
diventa desiderabile come un sogno.
La sala d’attesa in ospedale era grande e vuota nelle prime ore del giorno. Mi muovevo impacciata per non infrangere il silenzio.
Mauro accanto
perduti nei minuti che scorrevano
privi di parole
dimentichi di sentimenti.
Mi hanno chiamata a firmare un modulo che ho letto a strappi e poi ho riletto per non pentirmi e sbagliare. Ho pensato alle donne che al risveglio si erano ritrovate senza una mammella perché il chirurgo, sicuro che si trattava di cancro, aveva optato per una mastectomia tempestiva e, tremando nella ribellione, testarda nell’illusione di poter ancora decidere per la mia piccola vita, ho aggiunto di mio pugno che autorizzavo i medici ad intervenire solo per una biopsia e null’altro, pur se lo ritenevano necessario.
Quando l’infermiera è venuta a interrompere l’attesa, ho salutato Mauro con sollievo. Insieme, ci sentivamo abbrutiti dall’incognita, sola, sono diventata un pezzo di puzzle spostato alla rinfusa in cerca di un vuoto a cui adattarlo.
Mi hanno fatta spogliare ed infilare la vestaglia celeste con cui ho perso ogni identità per diventare un numero e una malattia. Il nome, per non dimenticarlo, è rimasto appeso a un braccialetto intorno al polso.
Il radiologo mi ha chiamata subito. Lo ricorderò sempre quel volto d’infelice che in un’altra cabina di tende color cielo mi ha infilato degli aghi nel seno. Prima un anestetico, poi aghi per circoscrivere il tumore perché fosse chiaro nella mammografia e il chirurgo lo trovasse senza problemi. Ma quanto male povero seno! Il radiologo pensava di avere tra le mani una massa informe e senza vita, non collegata a un corpo di dolore. Tirava la mammella, la infilzava in un andirivieni tra l’angolo dove mi lasciava in attesa e il laboratorio dove esaminava le radiografie. Ago, mammografia, aghi mammografie, per ammansire un tumore ribelle che giocava a nascondino mentre lui non aveva né voglia e né tempo di giocare.
Un’altra infilzata con rabbia
con disamore
non urlavo
nelle sue mani inghiottivo il dolore
ma il dolore si pianse da solo
lacrime inerti sul volto
fino a quando frustrato lui mi ha lasciata andare.
Dovevano operarmi subito, ma erano in ritardo e mi hanno fatta riposare in una stanza luminosa dove un’infermiera caritatevole è venuta ogni tanto a portarmi una rivista o un sorriso.
Ho letto, ho scritto righe di addio ai bambini intrise d’ironia e tenerezza e poi un pensiero per Mauro. Parole nascoste tra le pagine di un’agenda che forse nessuno avrebbe trovato mai.
Ho cercato di meditare, d’immaginare che l’operazione andasse per il meglio, che l’anestesista trovasse subito la vena e il chirurgo si astenesse da considerazioni negative sul mio conto. Se è vero che sotto anestesia la mente rimane cosciente ed è capace di ricordare in situazioni analoghe, sotto ipnosi per esempio – mi ripetevo come in un ritornello – allora qualsiasi cosa avvenga in sala operatoria entra nel subconscio del paziente e rimane lì, in un sottofondo torbido di paure e inibizioni. Volevo parlarne col medico, farmi rassicurare, ma non ho avuto il coraggio di farlo, la mia timidezza… quella di sempre.
L’ultima cosa che ricordo di stamattina sono le parole dell’infermiera che mi chiede di rilassarmi mentre m’inietta un liquido nelle vene e il mio arrivederci al mondo
ecco adesso vado via…
spero
di ritornare.
Poi le parole del chirurgo al risveglio, il bruciore nel corpo e la melma di nausea.
Gli avvenimenti della giornata sono tornati come in un flash nei pochi minuti di ritorno verso casa. Il dolore al seno è continuo ma sopportabile. Cerco di sorridere quando vedo la porta che si apre e i bambini correre verso di noi. Mi sembra di non abbracciarli da un’infinità, di provenire da un’altra epoca, come se avessi fatto un viaggio a ritroso nel tempo.
Sono diversa anche se faccio finta di nulla e loro percepiscono una realtà differente. Davide che ha dieci anni, non mi guarda negli occhi, li sfugge come per timore di scoprirvi qualcosa di penoso. Si rifugia nella sua stanza e chiude la porta, mi taglia fuori. Serena ha solo sette anni, viene a stringermi, mi tocca e mi accarezza come se avesse bisogno di ritrovare il mio corpo, mi prende per mano per andare a giocare con lei ora, prima di andarmene un’altra volta.